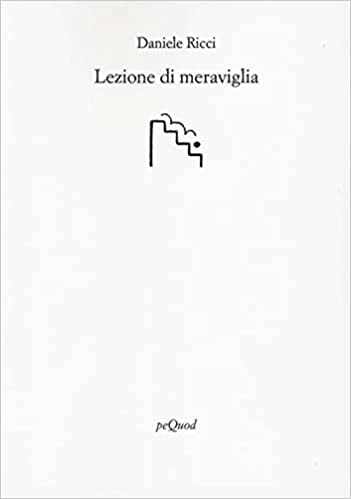
 La “lezione di meraviglia” – questo il titolo scelto per la sua seconda raccolta poetica, per i tipi di Pequod – di Daniele Ricci non è ammaestramento allo stupore, ma disponibilità a lasciarsi attraversare dal linguaggio, ad accoglierne l’ambiguità stupefacente: la parola libera e ingabbia; può sì far rapprendere le emozioni, addensarle, attribuir loro uno spessore, ma ugualmente è votata allo scacco nel corpo a corpo con ciò che non si può dire. Resta sempre uno scarto ultimo, un fondo di indicibile, un liquore che resiste alla cristallizzazione della sensazione nella lettera morta della scrittura, nella riduzione a logica grammaticale – e semantica – dell’alogico e asemantico sentimentale: «Mi tiro dietro uno strascico / di dolore senza fine / e non riesco a marginarlo / nella sintassi di una frase semplice». Sarà forse per questo che, dall’inconscia scaturigine della scrittura poetica di un autore che è anche insegnante e filologo, provengono soprattutto immagini marine e vitree: due marche in antitesi dialettica tra l’ingovernabile e il governato, tra l’abisso e il confine, l’eccesso e la cornice. E non è un caso che siano proprio «il dolore» e «il tradimento» a essere «di vetro»: è il dolore con e per il tradimento della lingua, amata e odiata poiché separa e ripara dal sentire, ma solo un po’, mai del tutto. In virtù della parzialità della sua azione protettiva, non risarcisce e non compensa, pur nella bellezza, la vitalità ammansita. Eppure i versi di questa raccolta sembrano anche accogliere, quasi con sentimento di fede, la possibilità che la parola non tanto «squadri da ogni lato» le cose che esistono e non si comprendono, ma faccia accadere quel che manca al e nel reale: al di fuori del dispositivo poetico, la vita non c’è, sfugge alla presa.
La “lezione di meraviglia” – questo il titolo scelto per la sua seconda raccolta poetica, per i tipi di Pequod – di Daniele Ricci non è ammaestramento allo stupore, ma disponibilità a lasciarsi attraversare dal linguaggio, ad accoglierne l’ambiguità stupefacente: la parola libera e ingabbia; può sì far rapprendere le emozioni, addensarle, attribuir loro uno spessore, ma ugualmente è votata allo scacco nel corpo a corpo con ciò che non si può dire. Resta sempre uno scarto ultimo, un fondo di indicibile, un liquore che resiste alla cristallizzazione della sensazione nella lettera morta della scrittura, nella riduzione a logica grammaticale – e semantica – dell’alogico e asemantico sentimentale: «Mi tiro dietro uno strascico / di dolore senza fine / e non riesco a marginarlo / nella sintassi di una frase semplice». Sarà forse per questo che, dall’inconscia scaturigine della scrittura poetica di un autore che è anche insegnante e filologo, provengono soprattutto immagini marine e vitree: due marche in antitesi dialettica tra l’ingovernabile e il governato, tra l’abisso e il confine, l’eccesso e la cornice. E non è un caso che siano proprio «il dolore» e «il tradimento» a essere «di vetro»: è il dolore con e per il tradimento della lingua, amata e odiata poiché separa e ripara dal sentire, ma solo un po’, mai del tutto. In virtù della parzialità della sua azione protettiva, non risarcisce e non compensa, pur nella bellezza, la vitalità ammansita. Eppure i versi di questa raccolta sembrano anche accogliere, quasi con sentimento di fede, la possibilità che la parola non tanto «squadri da ogni lato» le cose che esistono e non si comprendono, ma faccia accadere quel che manca al e nel reale: al di fuori del dispositivo poetico, la vita non c’è, sfugge alla presa.
«La mia partenza è liscia / il vento leggero / parla col mare / con le mie mani / e il nulla»: di sé, l’io lirico, soggetto diviso se non addirittura frantumato, salva la voragine che si produce accanto, tra le mani e il nulla, lo spazio apertosi tra lo strumento dell’azione, anche solo dell’atto di scrittura – si scrive sempre con le mani, anche quando si scrive con la mente, perché la scrittura è atto plastico-compositivo, è appunto poiesis –, e l’inerzia, la stasi, l’insensatezza di una realtà che può darsi solo in una marginatura di senso per così dire arbitraria, posticcia. Il significato è, infatti, questione esclusiva dell’umano, sua perversione, non esigenza immanente all’esistere delle cose («Tendo un braccio / afferro un senso», ma «il non senso contamina il senso»). Compaiono tante altre mani, e di conseguenza tanti altri tentativi, riusciti o no, di afferrare. Sono mani vive o agonizzanti – «Lentamente muore / la certezza della mano / nella casa digitale» –; mani proprie e altrui: «Un tempo orfano sbriciolato/ dove cede la tua immagine / il silenzio di lacuna / dentro l’acqua e la pelle scorticata. / Le tue mani non entrano / nelle mie parole». A chi appartengono queste ultime mani che non riescono a entrare in parola? Una lacuna della memoria (altrove «larva e fuoco»), nell’acqua uterina dell’origine indifferenziata, della beatitudine senza strappi, e nella pelle che è priva della sua corteccia, barra la presenza degli organi di contatto e di creazione, strumenti di mediazione tra sé e sé e tra sé e il mondo: senza mani, nulla può essere generato o preso; nessuno può essere toccato.
«La frattura mi tiene legato al mondo»: l’esperienza della spezzatura – di cui il componimento poetico, modalità espressiva disgregante e graficamente disgregata, si fa correlativo oggettivo – è sia benedizione sia maledizione. Come la parola, allontana e avvicina. Nella frattura, si sovrappongono impossibilità e possibilità dell’incontro: anche gli altri sono disarticolati e la mancanza è ciò che accomuna, ma nessuna mancanza può incastrarne un’altra. Lezione di meraviglia consegna al lettore un tentativo di bordare proprio quell’asimmetria irriducibile, ma nel contempo la esorcizza e la nega, in uno slancio verso l’assenza di sfrangiature, verso la perfezione dell’assoluto. Raggiunge un al di là dell’urgenza comunicativa che tende – e non può fare altro che tendere – all’aldilà, alla dimensione ultraterrena, al fuori tempo dell’idea compiuta, dell’essere che rifiuta l’evento-taglio e non si fa esistenza. Persino il passato fatica a incarnarsi. Si presenta, convocato, nella sua forma di patrimonio culturale interiorizzato – la tradizione poetica millenaria e globale, dai lirici greci ai contemporanei europei ed americani –, nell’andamento asincrono della liturgia mitologica, nell’emersione a intermittenza della ripetizione del teatro inconscio, dei fantasmi materni e delle memorie trasfigurate d’infanzia, ripassando l’enigma fondamentale, dalla risposta impossibile: «Poi / cos’è successo in quinta elementare / Che cosa m’ha fatto cambiare?». A tratti, si impone la cronaca, la contingenza che buca la ciclicità del tempo, affinché l’io lirico possa, nel cantarle, cucire insieme le sue ferite e quelle del mondo. Tuttavia, l’inattesa torsione civile non guasta il lirismo elegiaco che sigilla il tono dei componimenti in un’elegante uniformità di registro.
Per mezzo di una retorica, più che metaforica, analogica, in cui immagini quotidiane, quasi dimesse, s’alternano a impressioni rarefatte, e ai colori è assegnato il compito di simbolizzare l’ineffabile sentimentale, le poesie di Daniele Ricci rivelano, così, un talento paziente e stratificato che esige al lettore la pazienza di accedere gradualmente, con densa delicatezza, a ogni stratificazione del testo. Nel segno di una parola sinestetica – «il profumo sanguinante / della ginestra affiora /senza un predicato cordiale» – e sciamanica, nonostante apparenze contrarie di razionalità compositiva e di ipervigilanza linguistica.
Carolina Iacucci
Nota biografica – Nata a Fano nel 1988, Carolina Iacucci si è laureata ad Urbino in lettere classiche, con una tesi sull’influenza delle Baccanti di Euripide nel cinema e nel teatro bergmaniano; successivamente, ha completato i suoi studi a Bologna, laureandosi con una tesi magistrale sulla poesia neogreca del Novecento. Addottoratasi in Critica letteraria e letterature comparate all’Università di Firenze con uno studio sul rapporto tra romanzo greco antico e drammi romanzeschi shakespeariani, ora insegna Lettere al Liceo Nolfi di Fano. Ex Berlinale Talent Alumna, scrive di spettacoli online e su carta e collabora con alcuni festival di cinema. Dal 2014, è nello staff di Passaggi Festival, di cui, ogni anno, cura alcuni incontri per le diverse rassegne librarie.
Daniele Ricci è nato il 21 giugno 1967 a Fano. Originario di Marotta, viene da una famiglia modesta (i suoi genitori erano sarti). Dal 1990 non abita più nel suo paese: per dieci anni, per motivi di studio, ricerche postuniversitarie e docenze, ha vissuto in varie città italiane ed europee; poi, all’inizio del terzo millennio, è tornato nella sua terra e si è stabilito a Fano, dove tuttora vive e insegna al Liceo classico.
I suoi interessi vanno dalle lingue e letterature classiche (si è occupato in particolare di lirica greca arcaica ed alessandrina) alla poesia contemporanea (ha compiuto studi su Ungaretti, Montale, su Umberto Piersanti ed altri poeti marchigiani). Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio (fino alla nascita di sua figlia nel 2006) ha collaborato con alcuni periodici culturali. Nel 1998 ha pubblicato la raccolta di versi Lontananze (Montedit) e in questi ultimi anni sue poesie sono comparse in varie antologie e riviste letterarie.
Alla fine del 2022 è uscito il libro di versi Lezione di meraviglia (peQuod).
