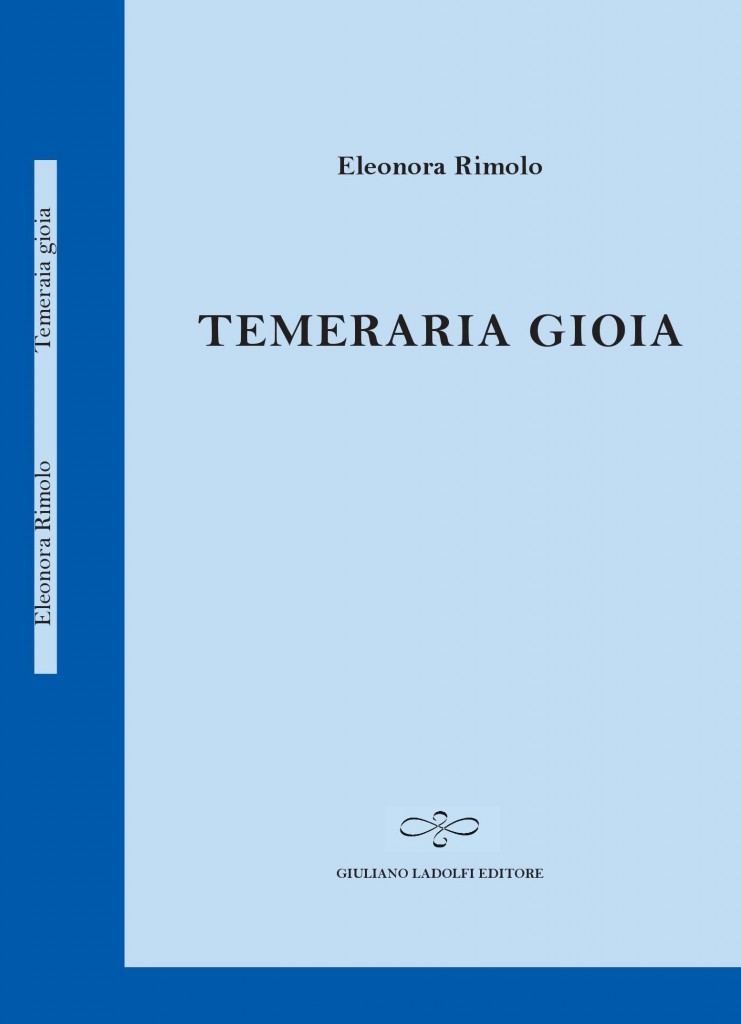
Eleonora Rimolo, Temeraria gioia
prefazione di Gabriella Sica
Borgomanero, Giuliano Ladolfi editore, 2017
 La poesia di Eleonora Rimolo è una scrittura di domande, che ha come oggetto di ricerca la “Temeraria gioia” del titolo, la quale, a sua volta, condensa le quattro anime del libro: le prime due sono tematiche in quanto la “gioia”, connotativamente positiva, è “temeraria”, cioè legata alla lotta, all’ostacolo (ma anche al temus-oscurità) e pertanto indicativa di un ossimoro che si andrà a trovare nelle pagine, con una forza più o meno irruenta ma costante; le altre due anime sono stilistiche perché se “gioia” può essere sia un termine letterariamente marcato che comune, certamente l’aggettivo “temeraria” indica un sostrato tradizionale più forte. Vi è, dunque, un doppio cordone ombelicale che nutre i versi della Rimolo: da un lato la vita stessa, dall’altro la sua esperienza di ricerca e di lettura. E non pare un caso che l’epigrafe sia tratta dal “buio Callimaco”, come diceva Montale nel suo Diario, con riferimenti al fuoco e alla cenere, cioè a quella turbolenza che contraddistingue la distruzione o la lacerazione. Questo accostamento, inusuale, non è un eccesso, ma la caratteristica di una lingua vitale che associa lemmi apparentemente distanti (come il comune “maniglia” e il classico “vaticinio”) e le cui punte di discostamento via via si assottigliano nelle tre parti in cui è composta la silloge.
La poesia di Eleonora Rimolo è una scrittura di domande, che ha come oggetto di ricerca la “Temeraria gioia” del titolo, la quale, a sua volta, condensa le quattro anime del libro: le prime due sono tematiche in quanto la “gioia”, connotativamente positiva, è “temeraria”, cioè legata alla lotta, all’ostacolo (ma anche al temus-oscurità) e pertanto indicativa di un ossimoro che si andrà a trovare nelle pagine, con una forza più o meno irruenta ma costante; le altre due anime sono stilistiche perché se “gioia” può essere sia un termine letterariamente marcato che comune, certamente l’aggettivo “temeraria” indica un sostrato tradizionale più forte. Vi è, dunque, un doppio cordone ombelicale che nutre i versi della Rimolo: da un lato la vita stessa, dall’altro la sua esperienza di ricerca e di lettura. E non pare un caso che l’epigrafe sia tratta dal “buio Callimaco”, come diceva Montale nel suo Diario, con riferimenti al fuoco e alla cenere, cioè a quella turbolenza che contraddistingue la distruzione o la lacerazione. Questo accostamento, inusuale, non è un eccesso, ma la caratteristica di una lingua vitale che associa lemmi apparentemente distanti (come il comune “maniglia” e il classico “vaticinio”) e le cui punte di discostamento via via si assottigliano nelle tre parti in cui è composta la silloge.
Non possiamo leggere quest’opera a stralci, ma nel suo ordine costitutivo, perché se, per l’appunto, la gioia ricercata è il fil rouge, è pur vero che essa si presenta, lessicalmente e tematicamente, sotto forme diverse nelle sezioni del testo, è la testimonianza, e qui l’azzardo interpretativo di chi scrive, di un passaggio dalla sofferenza come disagio alla sofferenza come elemento consustanziale all’esistenza: «Lì dove nacqui erano già in cammino / i tuoi passi, ancora e ancora / stritolano speranze / e – solo – il tuo amore fa ruggire / a me dentro tempesta. / Ci riabbracciamo qui sotto il letto, / aiuto, ho buttato via l’asso / di denari, sono stata davvero, ho fatto proprio la mossa sbagliata: tu / batti le mani, vincitore, il vino / ti colora rughe nuove e le Erinni / finalmente / abbandonano l’estate».
La clessidra, testimonianza del tempo lungo la linea Gozzano-Ungaretti-Montale, non mostra contorni dettagliati, ma sfigurati. Orfeo, figlio della poetica musa Calliope e inventore della cetra, secondo una delle tradizioni, che scende agl’Inferi per riportare in vita la donna amata, «chiama la morte, / in fondo, mentre chiedo / solo di rientrare col mio / morbo d’affetto / nella culla dell’acqua, / maschera impura e geniale»; sono le parole conclusive di un testo che riporta un’apostrofe alla madre e il rammento di un atto biologico-temporale ben preciso: «mentre mi iniettavi la vita». Si potrebbe azzardare ulteriormente che la Rimolo vada alla ricerca dell’identità primigenia e in questo caso ci si scontra con gli interrogativi: «E tu, che da quel seno / piangesti ogni frammento / del breve piacere, tu dove / tieni celato quel santo / liquido odoroso e franto? / Chi si è sfamato al posto / mio, dove l’hai svuotato / l’eccesso di quello spreco, / il mio nettare, / mentre sotto le gonne nere / e dentro le preghiere / la santa vita precipitava?». Se l’amore dapprima è la nausea del non capire, il suo fuoco (in un testo della seconda sezione) si tramuta nel riferimento indiretto alla salamandra che gioisce e che brucia, che vive nel fuoco e ne gode, a quella salamandra che va dai poeti antico-francesi a Petrarca, al “Morgante” di Pulci, alla calura novecentesca. Ma ogni riferimento ad una letteratura antica o passata, ogni suo valore viene contestualizzato nella variazione del nostro tempo e del nostro luogo sino, alcune volte, allo “scoronamento” bachtiniano: così leggerei l’aurora che non ha più le dita rosate, ma di prosa, o il “piè sospinto” omerici; così vedrei la variazione sciasciana del “cielo colore del vino”.
Anche se i rimandi dovessero essere filtrati o si trattasse di una intertestualità non voluta, una linea coraggiosa è segnata. Questa è la grande forza della poesia della Rimolo: «Sopra l’ultima pennellata / di confine io chiedo a te, / fuoco su altra luce, quella / oscurità dove affondo / il gomito e le fauci, / e nella cecità amo, / amo senza misura». Si manifesta tutto il desiderio dell’approdo, ma al contempo la necessità del naufragio: da qui la dialettica della raccolta, contrasto che appare più calmo nella consapevolezza che l’indomani è insondabile (Oggi non si percepisce più) e che «[…] il porto è segreto / nessuno sa / dove salpare». Tale coscienza, e conoscenza, di sé sfocia in quella preghiera laica che è espressione del viaggio intimo (scrutabile e semi-nascosto) di questi versi: «Ai miei dèi chiedo solo che non sottraggano / la fonte alla sete, che allontanino la tristezza / del non essere più, del non volere più, / feconda, come chi calibra i propri innesti / con quelli della terra, perché non sembri / prosciugata la madre corrente, la suprema viandante: / se questa è la promessa io invoco, io convoco / il mio mito, il mio sacrificio». Convocare e invocare il proprio mito e il proprio sacrificio sono atti di una presa di coscienza. In questo senso si realizza la nuova Lidia, che conferma un ulteriore legame con l’amore e con il tormento, ma che, come “pulvis et umbra” (titolo dell’ultima sezione), si trova in una condizione liminare e, in quanto tale, che “vede” da un altro punto d’osservazione. Più volte nel testo vi sono richiami al campo visivo e ciò è espressione dell’azione ancestrale della conoscenza, dell’analisi dell’anomalia. La gioia e la passione amorosa (o sentimentale) sono apparentemente dissociate, ma intimamente correlate, sono ambedue necessità temerarie.
Giuseppe Manitta
