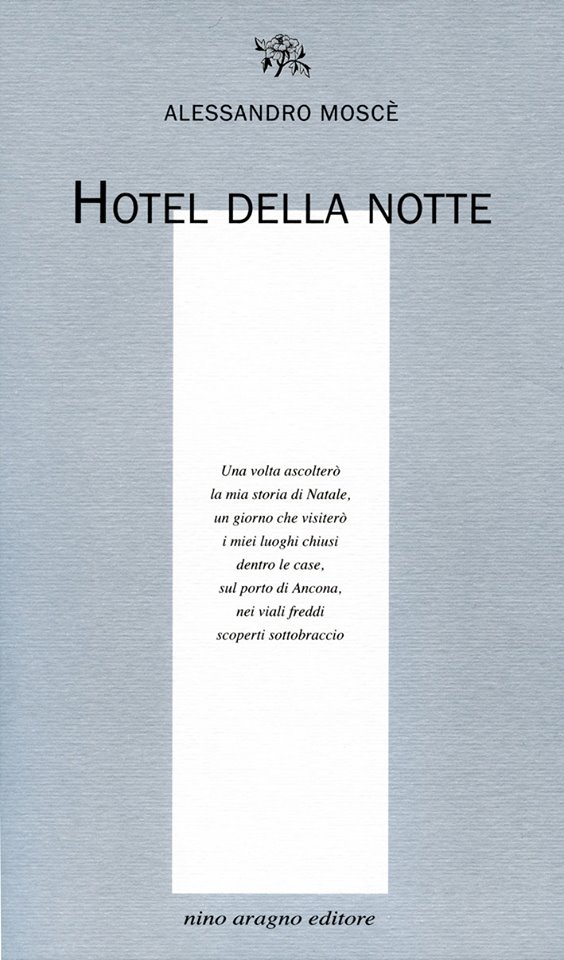
Pubblichiamo una recensione del nuovo libro di poesie di Alessandro Moscè, Hotel della notte (Aragno, Torino 2013).

Alessandro Moscè è un poeta neo-lirico, come molti altri nati negli anni Sessanta e Settanta, dei quali, però, manca colpevolmente un monitoraggio esaustivo sia di tipo verticistico, disposto secondo una scala di valori, che orizzontale, inteso in senso geografico. Non c’è, attualmente, neanche una mappatura orientativa che permetta di inoltrarsi lungo la parallela dello sperimentalismo e che si rifaccia a nomi tutelari quali Saba e Sereni, per citare due capisaldi della poesia italiana del secolo scorso, per giungere a Penna, a Caproni e a molti altri esponenti di primo piano di una linea tutt’altro che soppiantata da nuovi formalismi di maniera e da tendenze di moda improntate sulle performances e sull’encomio di un apparato prevalentemente gergale.
Lo conferma proprio l’ultima raccolta di versi di Moscè dal titolo Hotel della notte (Aragno, Torino 2013), che sviluppa una dimensione prioritaria di luoghi (l’autore ama definirli “domestici”) e una percezione immaginativa che consente di mettere idealmente in comunione i vivi e i morti, come del resto già verificatosi felicemente nel precedente libro di poesie Stanze all’aperto (Moretti & Vitali, Bergamo 2008). Nel frattempo Moscè è stato protagonista di un romanzo di grande successo sia nell’impatto con il pubblico che con la critica, e dal quale verrà tratto un film che uscirà nel 2014 nelle sale italiane. Stiamo parlando di Il talento della malattia (Avagliano, Roma 2012), giunto alla sua quarta edizione, che narra la guarigione di un tredicenne da un terribile sarcoma di Ewing alle ossa. Una biografia e insieme una storia di sport, allacciata indissolubilmente al campione Giorgio Chinaglia, attaccante della Lazio che Moscè conobbe di persona e che gli fu di sostegno morale durante il calvario dell’ospedalizzazione nei primi anni Ottanta, tanto da diventare il co-protagonista del lungo racconto.
Nel frattempo Moscè è stato protagonista di un romanzo di grande successo sia nell’impatto con il pubblico che con la critica, e dal quale verrà tratto un film che uscirà nel 2014 nelle sale italiane. Stiamo parlando di Il talento della malattia (Avagliano, Roma 2012), giunto alla sua quarta edizione, che narra la guarigione di un tredicenne da un terribile sarcoma di Ewing alle ossa. Una biografia e insieme una storia di sport, allacciata indissolubilmente al campione Giorgio Chinaglia, attaccante della Lazio che Moscè conobbe di persona e che gli fu di sostegno morale durante il calvario dell’ospedalizzazione nei primi anni Ottanta, tanto da diventare il co-protagonista del lungo racconto.
Tornando a Hotel della notte, questo metaforico albergo di una volta, sospeso nel tempo, forse senza aria condizionata, con mobili antichi, con una hall che raccoglie immagini invisibili scantonando nel tempo e oltre, è senz’altro l’espediente per rintracciare le figure familiari più care, il nonno materno su tutti, che diviene un’entità mitologica nella saggia parola pronunciata al nipote per anticipargli ogni domani, come fosse in un girone dantesco del paradiso e guardasse affaccendarsi gli umani di sempre. Quindi Alessandro Moscè entra di soppiatto in un’atmosfera esistenziale, dove gli spazi appaiono ridotti e dove viene proiettata ancora la vicenda dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo fa servendosi di un verso dall’andamento narrativo, ed in effetti il raccontare è lo svincolo di questa poesia fervida di costellazioni autobiografiche, di storie singolari, di vicende contemporanee tutte racchiuse fuori dalla sfera sociale e dirette allo scoperta di un’universalità illimitata. Non c’è confine da attraversare, e addirittura la stessa morte sembra miracolosamente annullata per sempre. Il libro si apre e si chiude con due dialoghi muti, notturni, in cui la totalità di una vita si confronta con il timore della sua stessa perdita. Moscè ha sempre alluso agli archetipi per ritornare all’eterno principio, ad un ciclo che non finisce mai, che potrebbe ripartire nell’affollato hotel che lo accoglie come visitatore o turista.
Alberto Bertoni, nella prefazione a Stanze all’aperto, scrisse di “un’esperienza biografica alla luce dell’esperienza poetica invitando il lettore a cogliere la fondante presenza dell’io lirico, che traspare attraverso una dominante di suggestioni visive, scandite dall’incedere cinematografico di una parola quasi sterilizzata…”. La stessa cosa avviene nell’ultimo libro, ma con in più un’accentuazione escatologica, come nei versi finali in cui Moscè si lascia andare ad una riflessione con il doppio di se stesso: “Ma dove sono, mio Dio? / Dentro la morte non preannunciata, / nel limbo dei vivi / ai quali hanno inflitto una pena?”. Una luce debole che arriva dal mare lo accompagna nel “niente” di stampo leopardiano, conciliato dal cielo opaco e dal volo del gabbiano sulla riva, dal merlo nella strada che costeggia il marciapiede. Questa esperienza, soprattutto sensitiva e nutrita dall’etica del dubbio, si conclude con il rientro nella normalità dopo le parole profetiche dal nonno: “Niente si cancella, / ti ho sempre visto, / ho riso con te, / anche per le partite la domenica. / Ma adesso torna indietro, / non è ancora ora / di dirci le cose / che non sappiamo dirci”. Non c’è mai un caos primigenio nelle enunciazioni, né una confusione terrestre per la visionarietà del cosmo, del dopo morte, come non si riscontra alcuna spersonalizzazione della materia, anche quando si persiste nell’individuazione di un infinito, di una ragione metafisica. Siamo, viceversa, dentro la percettività del dopo lirismo di matrice montaliana per affermare però una nuova lirica, un nuovo canto, dove saga ed elegia hanno un ruolo niente affatto secondario. Nella grande famiglia riunita intorno alla tavola, ad esempio, o nella ferialità della casa di riposo, in cui la sezione Suite per Pierino risuona altissima nella dinamica di questa sponda vita-morte, in una coabitazione da sognatore, in un posto di osservazione onnicomprensivo, sia esso l’hotel, la casa o il giardino pubblico che si manifesta come luogo iniziatico, vagamente crepuscolare, segreto: il luogo dell’amore, ma anche del passato che non torna, della prospettiva riflettente di quel dialogo con i morti al quale si faceva riferimento. Quasi che l’hotel e il giardino in particolare siano presaghi di un’apparizione, di una preghiera, di un’invocazione. La solitudine, pertanto, profonde un’energia salvifica, un discorso assorto e meditativo.
La sezione Suite per Pierino era stata pubblicata interamente sulle pagine di “Poesia” dei mesi luglio/agosto 2012 con una nota introduttiva di Maria Grazia Calandrone, la quale ha puntualizzato: “Questo di Alessandro Moscè è un requiem pieno del grande e pudico amore detto amicizia: nei confronti di uno tra gli ultimi della terra, un uomo che sostituì con Dio e la compagnia bella dei santi l’amore di una madre che lo respinse; uno col nome da barzelletta, che mai conobbe donna e si spense in una casa di riposo lasciando nel chiostro altrettanti mozziconi e un luccichio da interpretare – di lacrime o follia – nello sguardo dell’amico poeta. L’io narrante Moscè si va sdoppiando come una radice assai profonda nel noi dell’amicizia, nella diade consolante e affettuosa che, ripetendo insieme certi gesti divenuti consueti, dimentica in silenzio e senza smancerie un irrimarginabile abbandono. Dietro l’apparente domesticità delle piccole risa e delle chiacchiere, si apre la testardaggine infinita dell’immaginazione umana, la solida volontà di sopravvivenza di chi si oppone a una vertiginosa solitudine interna inventando una legione di santi e madonne protettrici”. In effetti anche l’omino della casa di riposo conserva una connotazione esistenziale: parla con Dio, con la Madonna, con San Nicola, con i morti. Nella sua emarginazione ricorda certi personaggi felliniesque, ma alla vena d’ironia unisce l’intuito creativo, la sensorialità. Struggente il testo in cui Moscè scrive: “Allora addio Pierino, / mi raccomando: / non fumare troppo, / metti l’orecchio nella crepa del muro, / ogni tanto, anche controvoglia. / La morte ci reinventa, lo sappiamo / e lo vogliamo credere, / sì, credere”.
Un leitmotiv che ricorre spesso si definisce nell’interrogativo sull’assoluto, come notato da Adriano Napoli nell’antologia Vola alta, parola, uscita da Marcos y Marcos nel 2011, dove il critico definisce Moscè un poeta che ingaggia una sfida amorosa, con “un’attrazione dell’infinito, così marchigiana, doverosamente, per un poeta cresciuto nel genius loci leopardiano, e l’incombenza di un senso del limite che tiene crudamente ancorati al suolo terrestre”. Basterebbe citare, da Hotel della notte, versi come: “Nella stanza si posa un po’ d’infinito, / un’ombra mobile accostata alla porta, / una domenica d’aprile, / nei riti quotidiani / e in un’antica calma / che si ama di nulla”. O ancora, rivisitando un’impressionistica visione dell’aldilà: “Mi avevi parlato di quel cammino / all’alba del primo marzo, / tu passeggero e testimone / di una lunga fila. / Eri senza biglietto, / ma quel Dio ti ha riconosciuto / al primo cenno”.
Alessandro Moscè attraversa paesaggi e cose, non è mai disincarnato dalla realtà che si scioglie nelle tante figure che compongono i suoi versi. Ma è capace di dare dignità alle cose, agli oggetti, ad un minimalismo animoso che si addensa nella quotidianità, nell’uso di uno specchio (“Il buio e il nonsenso, / uno scambio di persona / guardandosi allo specchio…”); nella luce (“Aspetta, aspetta sempre / la luce, / impigliata nella stanza dei segreti…”); nell’accendino (“Mi guardo vivo nello scatto dell’accendino, / come fossi un altro che mi abbraccia / davanti alla fontanella”). In poesia raramente le cose si vestono di sentimenti, ma in questo caso vengono custodite perché siano parte essenziale di uno spaccato di vita, perfino di un’epoca. Un’anima tenera si impadronisce di Moscè, di fronte alla caducità del tempo che corrode il palazzone delle scuole elementari e che porta il poeta a dire senza remore: “Dentro le stanze la memoria di un’epoca, / un banco, una lavagna, una cattedra, / un pulviscolo che luccica / e si posa a terra / sulla bianca malinconia”.
Nell’intervista rilasciata ad Eliza Macadan pubblicata su “Orizzonti culturali italo-romeni” (luglio-agosto 2013), Moscè sostiene: “Sono uno scrittore di luoghi e provengo dal magistero di Franco Scataglini, il poeta anconetano che ha coniato il concetto di «residenza». Che senso ha vivere qui e non altrove? Cioè in un luogo alienato come qualunque altro. La stessa cosa pensavano i kantiani. Il luogo, però, non è difensivo, localistico, ma universale. La postazione, cioè, per porsi quegli interrogativi che sono contenuti in tutti i miei scritti, su nascita, vita, morte, perdita, assenza, malattia: gli archetipi dell’esistenza che si prefigurano come una certificazione. E in questa ottica penso a Cesare Pavese, scrittore che amo molto, per cui le persone e le cose debbono venire a noi nell’unità del ricordo”. Un’unità che aggancia appunto uomini e oggetti, luoghi di una coscienza estrema, di una concretezza drammatica, che toccano l’incognita del destino. La tensione meditativa non si disfa, resta impressa nella certezza di un’indagine, di un gesto, di una parola strappata alla ritualità quotidiana, all’emozione che nasce da una vista (o visione), da un sogno, dai pieni e dai vuoti che aleggiano tra Fabriano, la città dove Moscè vive; Ancona, il nido dell’infanzia, dei genitori e dei nonni; Pesaro, la meta delle vacanze estive; Roma, la metropoli della memoria favolistica restituita dai racconti orali del padre al piccolo Alessandro.
Ha evidenziato Rossella Frollà nell’antologia Il segno della parola, data alle stampe nel 2012 da Interlinea, che il sogno di Moscè ha un’importanza costruente nella liberazione del sensibile: “Su un mondo osservato e contemplato a distanza si aprono tutte le rêveries che assicurano al poeta un’esistenza unitaria”. Le campiture sono in tensione nei luoghi come nell’amore. Un amore che si combina di situazioni sfuggenti, mai trattenute, come se l’hotel fosse una pausa distensiva nel mezzo di un incedere con orari e impegni prefissati e irrinunciabili. Eppure è proprio l’amore che risuona nel bisogno, nell’urgenza di esprimere la propria vitalità, nell’occhio soggettivo e abbandonato, nella cura dell’altro, nelle carezze e nell’atto sessuale. La prima parte di Hotel della notte, così come l’ultima, mostra diapositive rivolte al femminile: “Sono arrivati i trent’anni sottratti / all’adolescenza dei reggiseni, / all’età dei campari e delle discoteche. / Ma hai occhi che non cambiano / come i vestiti e i capelli, / gli unici occhi che resistono / ad ogni addio”. Un vago erotismo si snoda negli incontri occasionali, anche quando l’esperienza non è personale: “Al parcheggio nasce un amore al giorno, / un gesto di vita abbandonato / sui pantaloni di velluto dell’atleta / e sulle spalline della ragazza pallida”.
Alessandro Moscè si propone come un poeta che ama la tradizione, e ne appartiene ormai a pieno titolo. Non gli fa difetto l’apprendistato di una certa marchigianità assurta a livello nazionale con la presenza di poeti conclamati quali Umberto Piersanti, Gianni D’Elia, Francesco Scarabicchi e la consacrazione di un critico intelligente come Massimo Raffaeli, che di questa Marca ha contribuito a selezionare le voci più interessanti dell’ultimo trentennio. Del resto già l’esordio di Moscè, con L’odore dei vicoli (I Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme 2005), veniva salutato da Gianfranco Lauretano, nella prefazione, come segno di possibilità e di attesa, tanto che si specificava come queste due componenti determinassero “il confronto continuo con le poesie dei contemporanei, attraverso un’accorta regia di citazioni che serve ad allargare il senso e a far confluire un convegno di voci intorno ai temi cari all’autore”.
Ecco allora che l’hotel di Alessandro Moscè non è il “Grand Hotel” riminese immortalato tra ricatti, suicidi, danze, o per intravvedere schiene nude di donne allacciate da braccia maschili in smoking bianco che seducevano il grande Federico Fellini. E’ invece un albergo di provincia dove passa in rassegna addirittura il buio, la foschia, dove la vita e la morte prendono possesso delle terrazze e nel bar si accendono le luci. Il tempo di dileguarsi per ricominciare il trantran della settimana con i consueti rumori e ritmi.
Elisabetta Monti

1 commento a “L’infinitesima immortalità nell’Hotel di Alessandro Moscè”